L'ESPERIMENTO DI LENARD |
 |
Nel 1902 Philipp Lenard avviò una serie di esperimenti per determinare come l’energia dei fotoelettroni emessi dipendesse dall’intensità della luce. Come sorgente luminosa utilizzò una lampada ad arco di notevole potenza che gli permise una escursione in intensità di un fattore mille. Gli elettroni emessi dal fotocatodo finivano su una piastra metallica, il collettore, che era a sua volta collegato al primo mediante un filo conduttore attraverso un sensibile amperometro (Fig. 1): in tal modo era possibile misurare la corrente di elettroni prodotta dall’illuminazione. Per determinare l’energia degli elettroni emessi, Lenard pose il collettore ad un potenziale negativo rispetto al fotocatodo, in modo da creare un contro-campo elettrico che rallentasse gli elettroni stessi. In tal modo solo le particelle emesse con energia cinetica almeno uguale alla differenza di energia potenziale di un elettrone tra le due piastre avrebbero potuto giungere sul collettore dando luogo ad una corrente nel circuito. Il risultato abbastanza sorprendente delle misure così effettuate fu l’esistenza di una differenza di potenziale minima tra le piastre, in grado di arrestare completamente gli elettroni, del tutto indipendente dall’intensità della luce. Aumentando quest’ultima si osservava un aumento del numero di elettroni emessi (quindi dell’intensità della corrente), ma non della loro energia, in evidente contraddizione con le previsioni sopra delineate. Ma le sorprese per Lenard non finivano qui. |
|||
|
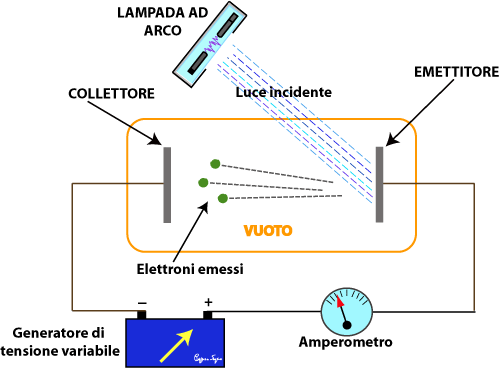 |
||
Infatti, grazie all’elevata potenza della lampada ad arco usata, fu in grado di studiare l’emissione fotoelettrica utilizzando le diverse componenti spettrali della luce, trovando così che la massima energia degli elettroni emessi dipendeva dal colore: la luce di lunghezza d’onda minore – ovvero di frequenza più elevata – provocava l’emissione di elettroni con maggiore energia. Queste misure non erano quantitativamente molto accurate, soprattutto a causa della rapidità con cui le superfici usate si ossidavano nel vuoto disponibile a quel tempo. Tuttavia lo erano abbastanza da permettere di stabilire le seguenti caratteristiche dell’emissione fotoelettrica:
Per comprendere l’impatto che tali evidenza sperimentali ebbero sui fisici del tempo, si provi a confrontarle con le previsioni avanzate al paragrafo precedente alla luce della fisica allora nota!
|
|||